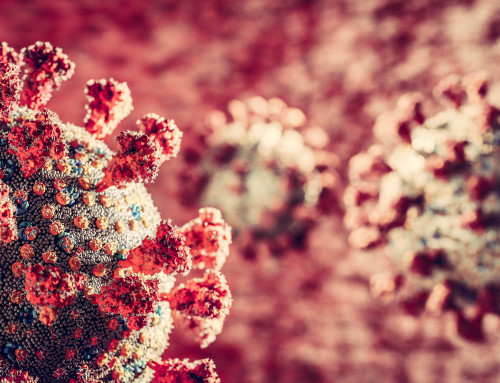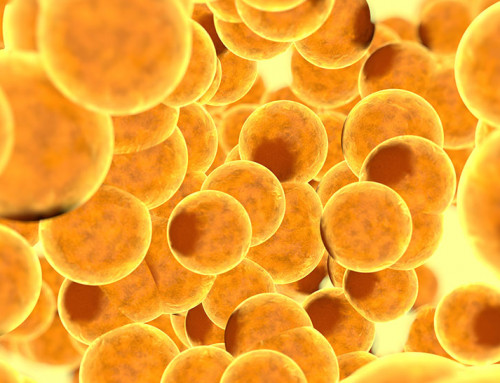Qualche tempo fa è rimbalzata sulle prime pagine di tutti i giornali una ferale notizia: l’ONU vorrebbe imporre ai prodotti tipici italiani etichette che equiparano le nostre eccellenze agroalimentari al fumo di sigaretta: rischi per la salute terribili, da evitare come la peste o, peggio ancora, da tassare pesantemente. Diciamo che si è esagerato un poco sul tasto del sensazionalismo, ma il fatto ci fornisce lo spunto per qualche considerazione sul nostro rapporto con i cibi che consumiamo, la loro provenienza e la loro salubrità.
È una tranquilla mattina di luglio del 2018 quando sulle pagine di uno dei più autorevoli quotidiani italiani compare una notizia di quelle terribili: l’ONU mette l’agroalimentare italiano sotto accusa, e a finire sul banco degli imputati sono olio d’oliva, grana padano e altri prodotti tipici italiani! ONU e OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) intendono ridurre di un terzo le morti per patologie cardiovascolari e diabete entro il 2030. Per farlo intendono limitare il consumo giornaliero di zucchero, grassi saturi, sale e alcol, fattori di rischio importanti per tutte le malattie che si vuol combattere.
L’articolo ci mette in guardia: tra gli alimenti indicati come problematici potrebbero finire delle eccellenze dell’agroalimentare italiano come il grana, il prosciutto e l’olio d’oliva, alimenti ricchi di sale e grassi saturi. Questi alimenti sarebbero stati definiti dannosi come alcol e fumo e sarebbero allo studio tassazioni e etichettature di stampo terroristico, alla stregua di quelle presenti sui pacchetti di sigarette.
Il danno economico potrebbe essere enorme e “l’industria agroalimentare non ci sta” dice la giornalista: l’iniziativa non solo danneggia le aziende ma anche i consumatori, visto che la correlazione tra certe componenti degli alimenti incriminati e le patologie indicate non è “esclusiva” ma dipende in realtà da molti altri fattori.
Levata di scudi immediati, baldi politici che aizzano la folla contro ONU e OMS, corrosive e sagaci critiche contro i poteri forti schiavi della Coca Cola Zero, lazzi e frizzi sull’appetibilità di una vasta rappresentanza di cibi stranieri, odi ai poteri salvifici dei prodotti italiani.
Molto rumor per nulla, avrebbe detto un drammaturgo inglese di un certo successo. L’articolo non riporta infatti alcuna indicazione sui documenti dove si indicherebbero misure di questo tipo e fa riferimento a un incontro in programma per il 27 settembre 2018 all’ONU come al “D-day” in cui verrà presentata una proposta che potrebbe prevedere tassazione o etichettature particolari per prodotti ad elevato contenuto di grassi saturi, zuccheri, sale e alcol.
Alcune testate che si sono occupate del problema hanno suggerito che alla base dell’articolo ci fossero le raccomandazioni contenute in un documento intitolato Time to deliver (lo potete leggere qui) pubblicato online il 1° giugno 2018. Il documento riporta le indicazioni che una commissione indipendente di alto profilo ha stilato per l’OMS sul tema della prevenzione delle malattie non trasmissibili.
A pagina 23 del documento vengono suggerite iniziative a livello governativo per incrementare la collaborazione con aziende, università e ricerca, società civile e comunità, per una regolamentazione più efficace e trasparente del settore: tra le misure indicate compare in effetti quella di restringere la commercializzazione di prodotti non salutari ricchi di zuccheri e grassi, in specie quelli per bambini, accanto ad un richiamo per nuovi sistemi di etichettatura e al possibile utilizzo di incentivi e disincentivi fiscali per ridurre la disponibilità e l’accesso a prodotti non salutari.
Da nessuna parte si fa cenno a prodotti specifici, tanto meno ai prodotti tipici del comparto agroalimentare italiano. Si tratta quindi di una situazione ancora fluida e tutta da discutere, con indicazioni che hanno a cuore la salute della popolazione generale e non hanno certo in animo di scatenare guerre commerciali a base di tasse, dazi e divieti di cui sicuramente non c’è alcun bisogno ( a meno che non siate un politico litigioso a caccia di voti facili: in quel caso lotte di questo tipo sono come il fango per i suini, motivo di sollazzo).
Etichette e tasse
Uno dei rischi paventati è l’introduzione obbligatoria dell’etichettatura a semaforo degli alimenti, un particolare tipo di etichettatura introdotto su base volontaria in Gran Bretagna e Francia, come fonte di informazioni ulteriori rispetto a quelle già presenti nella dichiarazione nutrizionale in etichetta.
Certo, prodotti come grana, prosciutto e olio sono decisamente ricchi di sale e grassi saturi e l’etichettatura a semaforo potrebbe in effetti penalizzarli, accostandoli ad alimenti dal pedigree meno nobile, decisamente più problematici per la salute. In realtà l’etichettatura a semaforo tanto temuta ha come scopo quello di di permettere ai consumatori di identificare in maniera semplice ed immediata gli elementi più importanti di un prodotto alimentare (energia, grassi e grassi saturi, zuccheri e sale) in modo da rendere possibile un miglior equilibrio tra i nutrienti della dieta.
L’idea del semaforo è proprio quella di evidenziare in maniera immediata alimenti problematici, dalle patatine fritte alle bevande zuccherate, ma anche prodotti insospettabili, ad esempio piatti pronti vegan, spesso ricchi di sale, e nello stesso tempo di permettere un rapido confronto tra prodotti analoghi che differiscono magari per alcuni degli ingredienti utilizzati. Insomma un metodo rapido per mettere in guardia contro i possibili eccessi legati al consumo di alcuni cibi.
Ovvio che un sistema di questo tipo funziona al suo meglio quando fa riferimento alle porzioni effettivamente consumate, porzioni che devono però essere realistiche e non manipolate ad arte da astuti responsabili del marketing. Inoltre la legislazione europea si è espressa contro l’obbligatorietà delle etichette a semaforo e prevede che alimenti con una lunga tradizione d’uso, tipici di diete equilibrate, come quella Mediterranea, possano essere esclusi da sistemi di etichettatura di questo tipo: il che mette olio d’oliva, grana e prosciutto al riparo dal terribile bollino rosso. [1]
Per quello che riguarda la tassazione dei cibi finora le esperienze in vari stati del mondo si sono concentrate su una tassazione di prodotti ad elevato contenuto di zuccheri (sugar tax), in particolar modo bevande gassate, e su sgravi fiscali per produzione e commercializzazione di prodotti freschi, soprattutto frutta e verdura. Più limitate le esperienze con tasse basate sul contenuto in grassi o sale. Molti dei dati disponibili provengono da proiezioni ed estrapolazioni e mostrano risultati decisamente variabili per quello che riguarda l’impatto sul consumo di prodotti non salutari e la riduzione nell’incidenza di patologie correlate a tali consumi. [2, 3, 4, 5]
Ad ogni modo va considerato che se l’etichettatura e la tassazione possono colpire e danneggiare la commercializzazione di alcuni prodotti tipici italiani, altrettanto avverrà per molti cibi prodotti in altre aree del mondo con un elevato contenuto di sodio, grassi o zuccheri.
In realtà uno degli obiettivi principali del documento OMS è la riformulazione di una gran numero di prodotti, in modo da ridurre progressivamente la presenza di quei nutrienti che presentano una correlazione forte con certe patologie; una iniziativa già avviata dal nostro Ministero della Sanità con “accordi volontari con l’industria alimentare e con le principali associazioni nazionali dei panificatori artigianali per riformulare una ampia gamma di prodotti disponibili sul mercato, a partire dal pane, prima fonte di sale nell’alimentazione degli italiani, ma anche gnocchi confezionati, primi piatti pronti surgelati, zuppe e passati di verdura surgelati”. [6, 7]
Di etichette con arterie occluse, cuori frantumati e fegati spappolati sulle bottiglie d’olio d’oliva o sulle confezioni di grana e prosciutto per ora non se ne intravede neppure l’ombra.
Un gran numero di cibi della tradizione sono ricchi di grassi, sale o zucchero. Non si tratta soltanto di cibi italiani: tutti gli oli, il burro, i formaggi, le carni conservate di ogni tipo sono alimenti sotto osservazione. L’obiettivo dell’OMS non è certo quello di penalizzare la produzione agroalimentare di alcuni stati a favore di altri, rinfocolando guerre commerciali che già politici di dubbia capacità e visione bramano di poter scatenare: il lavoro dell’OMS è semplicemente quello di dare indicazioni di massima relative alla salute e al benessere della popolazione, indicazioni che organizzazioni transnazionali e governi decideranno se seguire o meno.
In questo caso la commissione indipendente dell’OMS ha semplicemente indicato che un minor consumo di sodio, grassi saturi, zuccheri e alcol, potrebbe ridurre l’incidenza di un gran numero di patologie nella popolazione in generale: assieme a un minor consumo di alcolici, all’astinenza dal fumo e a un deciso aumento dell’attività fisica (forse che si vuole favorire la lobby dei produttori di scarpe da ginnastica a scapito dell’industria automobilistica?). Nulla di nuovo, nulla di eccezionale: a meno che non si dia una interpretazione della notizia che va molto oltre le poche righe presenti nei comunicati di partenza.
Se l’Italia vuole difendere la bontà dei propri prodotti tipici può certamente farlo nelle appositi sedi, con l’intervento dei Ministri competenti, senza montare tempeste mediatiche che non hanno giustificazione nei documenti che abbiamo a disposizione.
Una riflessione: tipico=buono?
Capisco benissimo le preoccupazioni di chi si occupa del settore agroalimentare, un settore difficile dove sono già molti i fattori che influiscono sulla resa economica di produzioni che devono farsi spazio in un mercato agguerrito ed estremamente competitivo. Ed è evidente che sarebbe grottesco assimilare a certi cibi spazzatura l’olio extravergine d’oliva o certi formaggi italiani. Non mi avventuro in analisi commerciali che l’effetto di una etichettatura sconsiderata o tassazioni elevate — di cui però nessuno parla, abbiamo visto — potrebbero avere. Sono un nutrizionista e non ho gli strumenti per giudicare queste situazioni.
Quello su cui mi voglio soffermare, e su cui vi invito a riflettere è un atteggiamento che spesso ho osservato tra i miei pazienti e che questa sfortunata vicenda mediatica ha esaltato in misura importante: l’atteggiamento di chi, consumando soprattutto prodotti tipici italiani, meglio ancora se acquistati dal contadino fuori porta, è convinto di mangiare in maniera salutare, irreprensibile, ottima per la salute sua e dell’orbe terracqueo.
“Dottore, noi abbiamo il nostro olio d’oliva, le nostre uova, il prosciutto del Norcino DOP, la pasta IGP, il formaggio DOC, il sale delle saline con tutti i minerali, il pane coi grani antichi, la carne DOCG allevata a foraggi delle colline appenniniche: possiamo fare di meglio?”
Sì. Possiamo fare parecchio di meglio. Non c’è dubbio che la qualità del cibo che consumiamo sia importante, ma lo è in misura ancora maggiore la quantità che consumiamo. E purtroppo per molti il meccanismo scatta automatico: se il cibo è di buona qualità allora posso mangiarne di più, che non fa mica male come quelle schifezze piene di roba chimica che si trovano in giro. Purtroppo non è cosi: la quantità conta ed è più importante della qualità in ultima analisi, per cui anche di fronte alle nostre tipicità e alle nostre eccellenze, come le definiscono quelli del marketing, bisogna fare attenzione e consumarne la giusta quantità. Quantità che dipende da molti fattori, età, sesso, costituzione, livello di attività fisica, ma non dipende certo dall’origine o dai bollini del cibo che intendiamo mangiare.
Un alimento tipico, della tradizione, slow, rispettoso della sapienza contadina (e della disposizione dei filari come da disciplinare allegato), ma tuttavia ricchissimo di sale e grassi saturi resta sempre un alimento da consumare con grande attenzione, in occasioni particolari: non è il salvifico cibo degli dei che una certa comunicazione vorrebbe farci credere.
L’olio extravergine d’oliva è davvero uno dei pilastri del modello mediterraneo — decisamente meno grana o prosciutto — ma gli ingredienti veri della Dieta Mediterranea, del tanto bistrattato modello mediterraneo ridotto ormai a una parodia di sé stesso, sono solo due e non si mangiano: per dirla in maniera brutale sono (erano?) la fame e la zappa.
Non bisogna tuttavia cadere nella trappola opposta e considerare ogni alimento come la semplice somma dei suoi nutrienti: è vero che dietro ognuno dei cibi che consumiamo ci sono caratteristiche organolettiche cui il territorio di origine, una tradizione consolidata e la cultura di chi produce e lavora danno un contributo enorme, essenziale per la natura e il gusto del prodotto.
Il nostro paese è una vera miniera d’oro per chi ama il cibo e la buona cucina. Abbiamo prodotti tipici che davvero il resto del mondo ci invidia. Una miniera d’oro anche in termini economici, da sfruttare e valorizzare sul mercato mondiale. Per farlo non abbiamo, non dovremmo, aver bisogno di creare il panico attorno a indicazioni il cui unico scopo è quello di migliorare la salute della popolazione generale.
Certi cibi tipici, al cuore delle nostre tradizioni, sono ricchi di sale, di grassi saturi di zuccheri o alcol. Non è un problema se li mangiamo in maniera consapevole, consumandone le giuste porzioni, che possano soddisfare il gusto senza creare problemi per la salute. Ma non possiamo nemmeno negare la realtà in difesa di un orgoglio di bandiera che, quando si parla di salute, non è certo l’aspetto principale da considerare.
Per saperne di più sul tema del rischio potete leggere questi articoli: